Campani Erica; Dan Vanessa.
IL PRAGMATISMO AMERICANO
Il pragmatismo fu una scuola filosofica che nacque negli Stati Uniti verso la fine dell'Ottocento e solo in seguito si diffuse in tutta Europa.
La nascita di questa filosofia venne influenzata dalla teoria dell'evoluzione di Darwin, secondo cui l'uomo è sempre in rapporto stretto con l'ambiente che lo circonda.
I pragmatisti interpretarono la filosofia come strumento utile all'uomo per adattarsi all'ambiente ciò appunto in analogia con la teoria evoluzionistica di Darwin.
Secondo la filosofia pragmatica qualsiasi teoria non ha un valore teorico, oggettivo, ma pratico cioè essa è utile se serve alla vita e all'azione dell'uomo.
Una teoria essendo controllabile dall'esperienza futura si può considerare vera se la capacità predittiva di questa sarà confermata.
La caratteristica del pragmatismo è appunto quella per cui i pragmatisti si orientano verso il futuro anzichè verso il passato o il presente: essi basano la loro filosofia non su prove già esistenti ma su quelle che si possono presentare a sostegno delle teorie scientifiche e filosofiche, di conseguenza non si orientano ad interpretare il passato ma si orientano verso il prevedere, progettare, controllare il comportamento dell'uomo. Così facendo i pragmatisti distinguono la filosofia pragmatica dall'empirismo classico inglese. L'Empirismo sottolinea il fatto che l'esperienza è considerata come fonte unica di conoscenza. Il pragmatismo, invece, considera l'esperienza come la previsione e l'anticipazione degli sviluppi di certe condizioni.
Il pragmatismo americano si distinse in due correnti fondamentali: il Pragmatismo Metodologico e il Pragmatismo Metafisico; le due correnti svilupparono in modo diverso il rapporto tra conoscenza e azione.
Il pragmatismo metodologico, il cui esponente fu Dewey, si presenta come una teoria del significato; il pragmatismo metafisico, il cui esponente fu James, si basa sulla teoria delle verità e sulla realtà.
Queste due forme di pragmatismo sono diverse, in quanto uno ha inizio con un razionalismo sperimentale e fallibilistico; l'altro sfocia in irrazionalismo metafisico e religioso.
JOHN DEWEY (1859-1952)
VITA E OPERE
 John Dewey nacque nel Vermont (USA) nel 1859. Dopo la laurea con una tesi sulla psicologia di Kant, nel 1894 passò ad insegnare alla University of Chicago dove, pur insegnando filosofia, dedicò grande impegno scientifico alla pedagogia. Prima della fine del secolo uscirono due opere fondamentali:
John Dewey nacque nel Vermont (USA) nel 1859. Dopo la laurea con una tesi sulla psicologia di Kant, nel 1894 passò ad insegnare alla University of Chicago dove, pur insegnando filosofia, dedicò grande impegno scientifico alla pedagogia. Prima della fine del secolo uscirono due opere fondamentali:
- "Il mio credo pedagogico" (1897)
- "Scuola e società" (1899)
queste due opere sono il risultato delle ricerche sperimentali svolte presso l'University of Chicago Elementary School, una scuola sperimentale, fondata nel 1896 assieme alla moglie, annessa all'Università.
Nel 1905 si trasferì alla Columbia University (New York), ove rimarrà fino al 1929. Risalgono a questo periodo opere quali "Ethics" (1908), "How do we think" (1910), "Democracy and education" (1916), "Human Nature and Conduct" (1922), "Experience and Nature" (1925), "The source of a Science of Education" (1929).
Dopo l'abbandono dell'insegnamento universitario Dewey si dedicò ad un'attività di puntualizzazione delle sue teorie filosofiche e pedagogiche interessandosi a questioni sociali e politiche. Morì nel 1952. Fra le sue ultime opere si possono ricordare:
"A common Faith" (1934), "Logic the theory of Inquiry" (1938), "Experience and Education" (1938), "Education Today" (1940).
LO STRUMENTALISMO DI JOHN DEWEY
Secondo Dewey la conoscenza è parte dell'esperienza, la logica non può essere separata dalla ricerca scientifica, le idee non sono altro che "strumento" indispensabile per l'uomo in quanto utili all'agire in favore dei propri fini pratici; la loro utilità è data dai risultati.
Le idee, essendo semplici previsioni di ciò che si potrà verificare in seguito a determinate operazioni, non hanno un valore oggettivo.
Anche i simboli linguistici sono strumenti d'azione; il linguaggio ha molta importanza per lo sviluppo delle conoscenza astratte.
Il pragmatismo di Dewey prende il nome di strumentalismo, in quanto concepisce l'intelligenza dell'uomo come strumento in grado di risolvere i problemi della vita; la vita esiste in quanto vi è una relazione dinamica tra soggetto e oggetto.
L'uomo va riconosciuto come unità di persona tra il corpo e la sua anima. Esso interagisce con l'ambiente in quanto l'ambiente pone problemi che l'uomo deve risolvere elaborando delle idee. L'uomo per risolvere i problemi posti dall'ambiente utilizza l'intelligenza, la quale procede per tentativi ed errori.
L'uomo si trova quindi ad elaborare le ipotesi e le modifica in base alla realtà. Si può dedurre che la conoscenza dell'uomo è in continuo mutamento e non vi è una differenza sostanziale tra conoscenza quotidiana e conoscenza scientifica; entrambe permettono di capire cosa accadrà nell'ambito del contesto attuale.
Dewey per sviluppare la propria filosofia si basa sul concetto dell'evoluzione interpretata da Darwin.
La conoscenza essendo essa stessa una forma di comportamento si può spiegare con gli staessi mezzi con cui il naturalista spiega i comportamenti degli animali.
Lo strumentalismo di Dewey fu sostanzialmente una teoria generale dell'indagine per affrontare le problematiche dell'esistenza.
- Nel primo momento dell'indagine la logica non ha per oggetto operazioni linguistiche, ma delle operazioni esistenziali.
- Nel secondo momento vi è lo sviluppo di un'idea mediante il ragionamento.
- Il terzo momento consiste nelle osservazioni e nell'esperimento: si tratta di saggiare le varie ipotesi prospettate.
- Il quarto momento consiste in una rielaborazione intellettuale delle precedenti ipotesi.
- Il quinto momento vede l'indagine giungere a formulare nuove idee e alla loro verificazione.
L'ESPERIENZA
Secondo Dewey il punto di partenza della filosofia è l'analisi dell'esperienza che assume il significato di totalità e che vede l'uomo in stretto rapporto con l'ambiente in cui vive.
Solo con l'esperienza si può comprendere la persona e gli eventi della società; l'esperienza è dunque una realtà oggettiva mirata al cambiamento della società data.
Secondo Dewey il pensiero e le cose materiali sono prodotti che si costruiscono all'interno dell'esperienza. Le sensazioni interne alla mente sono un prodotto della riflessione intellettuale. L'esperienza in origine si manifesta nei modi fondamentali dell'avere o dell'essere. Una qualsiasi azione (mangiare, parlare, gioire, ecc.) è esperienza quindi l'aspetto cognitivo non è mai primario.
L'INDAGINE
Per indagine Dewey intendeva esprimere il conflitto determinato da un ostacolo che si oppone all'agire, l'indagine consiste nell'unico mezzo in grado di superarlo. L'esperienza produce le idee dando forma "ai piani di azione" o "ipotesi di lavoro" nelle quali vi sono suggerimenti su come risolvere situzioni problematiche. Attraverso il ragionamento abbiamo quindi l'elaborazione delle idee. Se un'idea ci conduce alla soluzione del problema possiamo dedurre che è vera, in quanto ci mette in condizioni favorevoli per risolvere il problema. Il risultato finale dell'indagine è il giudizio che stabilisce la nostra decisione nel risolvere il problema.
SOGGETTO E OGGETTO
Attraverso il processo dell'indagine si formano un soggetto e un oggetto. Il soggetto si sviluppa quando vengono sviluppati ed elaborati i piani operativi in grado di risolvere dei conflitti. L'oggetto è l'insieme delle caratteristiche delle distinzioni connesse risultanti nell'esperienza con la risoluzione del conflitto. Giungiamo così al prodotto conclusivo della conoscenza. Il soggetto e l'oggetto non sono mai entità isolate e contrapposte ma sono strettamente collegate tra loro.
L'ETICA DI DEWEY
Nella sfera etica Dewey ribadisce il proprio naturalismo respingendo così la contrapposizione tra i valori e la realtà dei fatti. Anche nella morale, Dewey, utilizzò il metodo sperimentale. Attraverso gli ideali morali l'uomo cerca di cambiare l'ambiente. I valori morali, afferma Dewey, "non sono paragonabili a un pugno di monete nascoste in una scatola"(1), ma devono essere considerati come "una pianta alla luce del sole e radicata nel terreno"(2).
Secondo Dewey " L'azione morale è il frutto della capacità dell'uomo di potenziare il controllo delle situazioni filosofiche [...] deve favorire l'inserimento di ciascun individuo in essa plasmando la cultura della collettività e dei singoli in modo da realizzare il migliore equilibrio tra individuo e collettività".(3)
L'EDUCAZIONE PROGRESSIVA
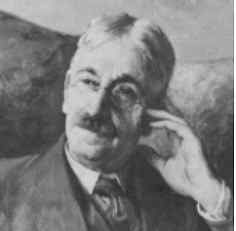 Dewey criticò, nella scuola tradizionale, la dimensione intellettuale e quella pratica e sostenne un apprendimento basato sul fare: Learning by doing (apprendere attraverso il fare). La scuola deve riprodurre al suo interno la società; essa è una forma di vita dove il bambino ha un'attività sociale e i suoi interessi diventano il centro del progresso educativo.
Dewey criticò, nella scuola tradizionale, la dimensione intellettuale e quella pratica e sostenne un apprendimento basato sul fare: Learning by doing (apprendere attraverso il fare). La scuola deve riprodurre al suo interno la società; essa è una forma di vita dove il bambino ha un'attività sociale e i suoi interessi diventano il centro del progresso educativo.
In generale l'educazione appare come la crescita dell'esperienza, diventa lo strumento attraverso cui possono essere diffusi gli ideali della democrazia.
CARATTERI DELLA SCUOLA AMERICANA
A livello dei singoli Stati, la scuola veniva gestita o dalla Pubblica amministrazione, o veniva delegata alla Local Education Agency. In ogni Stato troviamo un Ministero dell'Educazione, il cui compito è quello di ricerca e collegamento, determinando alcuni standard comuni degli alunni. Il principio comune di tutti gli Stati è l'istruzione fino a diciotto anni.
Il curricolo si articola in:
- dai tre ai sei anni, il bambino frequenta una Nursery School;
- Seguono dodici anni di scuola articolata in moduli diversi, che possono essere:
- Scuola primaria + scuola secondaria quadriennale (8+4)
- Scuola primaria + Junior High School+Senior High School (6+3+3)
- Scuola primaria + scuola secondaria (6+6)
Negli Stati Uniti l'attivismo si sviluppa con l'opera di John Dewey. Dewey forma una scuola attiva fino agli anni Cinquanta. Durante la Guerra Fredda si sviluppa una "corsa" tra gli Stati Uniti e l'URSS per la supremazia tecnica e militare, e anche a causa di queste esigenze Bruner lancia la cosiddetta "sfida pedagogica americana"(4), caratterizzata dal superamento dell'attivismo di Dewey e dal bisogno di programmare la costruzione dei curricoli di studio, sottolineando le mete raggiungibili e gli itinerari di istruzione.
Dewey impostò la sua ricerca in campo educativo contro le chiusure ideologiche, politiche e sociali: una scuola alimenta lo spirito democratico ma, per essere avviata, occorre il superamento di alcuni vecchi steccati, propri dei sistemi autoritari.
Dal 1896 al 1903 Dewey si occupa dell'organizzazione della "Scuola Laboratorio", articolandola in livelli corrispondenti agli studi dello sviluppo psicologico.
Il primo livello è quello della scuola primaria, dai 4 ai 6 anni, dove i bambini soddisfano i loro interessi elementari come, ad esempio, il cubo e la casa. L'attività prevalente è il gioco e la collaborazione con gli adulti in piccoli lavori di gruppo. Tra i sei e i sette anni è caratterizzato dalla scoperta di giochi di costruzione, e si propongono le premesse della scuola primaria, che va dagli 8 ai 12 anni. Il lavoro principale nella scuola elementare è svolto in laboratorio: gli alunni sono impegnati in lavori come la falegnameria, la cucina e la tessitura.
Dai 14 ai 18 anni l'alunno affronta la scuola secondaria che deve essere pre-professionalizzante, ma nello stesso tempo formativa. Dopo i 18 anni la competenza specifica nei vari settori è affidata all'Università, considerata da Dewey come centro di ricerca attivo e dinamico.
DEMOCRAZIA ED EDUCAZIONE
Nel 1916 Dewey pubblicò Democrazia ed educazione , dove, riprendendo le tesi del Credo pedagogico, definisce l'educazione come continuità sociale: legame organico tra individuo e società.
La scuola è un ambiente per il bambino deputato a guidare l'esperienza infantile e a mettere il piccolo in grado di conoscere un ambiente più vasto e di partecipare ad un'esperienza più complessa.
L'educazione, secondo Dewey, valorizzando l'esperienza, favorisce così la crescita. Come l'esperienza è un continuo fluire e un continuo sviluppo, la crescenza si svolge in una direzione in parte imprevedibile.
Alla luce dell'esperienza Dewey sottopone sotto l'occhio critico la ricerca della pegagogia e della psicologia più note.
L'apprendimento viene spiegato come uno stimolo esterno dalla psicologia scientifica. Contro questa tesi, Dewey critica il fatto che il soggetto è sempre attivo e partecipe nell'apprendimento, in quanto l'uomo apprende le cose in base all'utilizzo che ne fa. Con questo possiamo notare lo strumentalismo pedagogico di Dewey.
Nel capitolo VII dell'opera Democrazia ed educazione, Dewey prende in considerazione tre tipi di filosofie dell'educazione. Qui riconosce di essere vicino alle idee di Platone, il quale considera la formazione come processo sociale; la differenza tra i due consiste nel fatto che Platone considerava come unità sociale la classe, mentre Dewey considera l'individuo. Nel cosiddetto "individualismo illuministico del XVIII secolo"(5), che culmina soprattutto con Rousseau, sviluppa l'idea di una società vasta come l'umanita, in cui l'individuo deve essere l'organo principale. Nella filosofia idealistica, soprattutto con Hegel, il principale mezzo utile per garantire l'educazione è lo Stato nazionale.
Dewey, attraverso questo, dimostra "l'inutilità di stabilire lo scopo dell'educazione"(6), in quanto è distante dal continuo fluire dell'esperienza. Di conseguenza Dewey critica come antipedagogico il dualismo, iniziando dal contrasto tra individuo e società e tra cultura e spontaneità. Nel continuo fluire dell'esperieza gli scopi sono ipotesi di lavoro, Dewey spiega che: "qualsiasi attività che tende ad uno scopo implica una distinzione tra una precedente fase incompleta e una fase ulteriore che la completa, implica anche dei passaggi intermedi. Avere un interesse significa considerare le cose come rientranti in una tale situazione in continuo sviluppo, invece di considerarle isolate."(7); questo implica, però, sforzo, volontà, capacità di attenzione.
I PRINCIPI DEL METODO PEDAGOGICO DI DEWEY
Dewey, rifacendosi a Hegel, sostiene che, nel trascorrere dell'esperienza, il metodo fa parte dell'attività del pensiero. I principi del metodo si possono sintetizzare in cinque punti:
- Il bambino deve partire da "un'attività genuina di esperienza".
- Bisogna affrontare un problema reale, in modo tale che venga stimolato dal pensiero.
- Al bambino va dato del materiale formativo, che lo aiuti nelle ricerche e nella indagine.
- Il bambino potrà sviluppare, così, le soluzioni che gli vengono in mente.
- Fare in modo che il bambino possa applicare le sue idee, chiarirne il significato e scoprire la verità.
Dewey contesta altre opposizioni quelle tra lavoro e svago e tra studi intellettuali e pratici, che vengono superati.
"La realtà è un continuo fluire, ma non è solo un fatto pratico. l'azione si carica di tutti i suggerimenti del pensiero, per cui l'esperienza cessa allora di essere empirica e diventa sperimentale"(8).
L'educazione democratica è sociale e pertanto è morale. L'assenza di un adeguato spirito sociale mette in crisi il lavoro scolastico, in quanto con la sua mancanza "non è possibile il consolidamento morale"(9)
.
GLOSSARIO
EDUCAZIONE
"L'educazione è stata posta al centro dell'attenzione dalla filosofia di Dewey. Essa è, in generale, un processo di crescita dell'esperienza, attraverso cui l'esperienza stessa si arricchisce di prospettive sempre più ricche e attraverso cui i soggetti accrescono il proprio potere di controllare il corso degli eventi. Il processo educativo, secondo la visione che Dewey chiama educazione progressiva, deve, in conformità alla precedente caratterizzazione, mantenere un rapporto di continuità con l'esperienza precedente del soggetto e deve permettere quell'interazione con l'ambiente che rende possibile l'arricchimento dell'esperienza. Essa, pertanto, deve prendere le mosse dai concreti interessi dei soggetti e deve basarsi sulla loro attività, in una prospettiva che accentui e valorizzi la socialità. L'educazione è, secondo Dewey, lo strumento precipuo attraverso cui si possono affermare e consolidare i valori della democrazia."(10)
ESPERIENZA
"La concezione dell'esperienza che viene sviluppata dagli autori del pragmatismo americano è profondamente innovativa rispetto a quella dell'empirismo di Locke, Berkeley e Hume. In generale l'esperienza tende a presentarsi, soprattutto con Peirce e Dewey, non più come una sequenza di stati di coscienza interni alla mente e sostanzialmente "privati", ma come un flusso di eventi che esistono per tutti gli osservatori e che, in generale, possono essere pubblicamente sperimentati da tutti. Solo in casi particolari contenuti dell'esperienza sono interni a una singola coscienza. Inoltre, secondo le varie concezioni riconducibili al pragmatismo, l'esperienza, anziché frammentarsi in una molteplicità di elementi separati (come erano, per esempio, le "idee" di Locke), è connessa al suo interno da relazioni che sono anch'esse a pieno titolo sperimentabili."(11)
GIUDIZIO
"Secondo Dewey è l'atto conclusivo dell'indagine. In quanto tale esso è sempre individuale, ossia riferito a un caso singolo; rappresenta la sistemazione del problema da risolvere e contiene le decisioni relative al comportamento futuro. Si distingue dalla proposizione che rappresenta, piuttosto, un'ipotesi provvisoria di soluzione del problema."(12)
IDEA
"Secondo Dewey è "una possibile soluzione" del conflitto che ha dato origine al processo di ricerca. Questo uso del termine si discosta da quello che prevale nella filosofia moderna a cominciare da Descartes, secondo cui l'idea è l'oggetto immediato della coscienza. Per Dewey essa l'idea, essenzialmente, è un piano di azione mediante cui noi progettiamo la soluzione di un problema."(13)
OGGETTO
"Con questo termine Dewey denomina ciò che "è stato prodotto e ordinato in forma sistematica per mezzo dell'indagine" (Logica, teoria dell'indagine, cap.VI). In tal senso l' "oggetto" non è antecedente alla ricerca stessa, non essendo dato e costituito prima della conoscenza, ma è, piuttosto, l'obiettivo finale a cui essa mira."(14)
RELIGIONE
"Secondo Dewey è essenzialmente il nome che noi diamo al rapporto attivo tra l'ideale e il reale. In altre parole la religione è la fede nella possibilità di trasformare il mondo per mezzo dei nostri ideali; l'atteggiamento religioso è quello di colui che abbraccia gli ideali accettandone coerentemente tutte le conseguenze. Questo è, come si vede, un modo di intendere la religione conforme al "naturalismo" professato dal filosofo statunitense."(15)
TRANSAZIONE
"Nella terminologia di Dewey è la relazione che non presuppone come già esistenti i termini che vengono correlati. E' una "transazione" il rapporto tra il soggetto e l'oggetto perché entrambi si costituiscono nel corso dell'esperienza e non sussistono al di fuori di questo reciproco rapporto."(16)
VERITÀ
Con il pragmatismo vengono a cadere i tradizionali concetti di "verità" intesa come corrispondenza, o adeguazione, nei confronti di una preesistente realtà esterna alla mente, oppure rapporto tra contenuti mentali e coerenza interna al pensiero. I vari autori che condividono l'ispirazione di fondo del pragmatismo elaborano, tuttavia, concezioni della verità piuttosto diverse l'una dall'altra. Così, secondo Peirce, la verità scientifica è la meta ideale a cui tende la credenza della comunità scientifica in un futuro infinitamente lontano; in ogni caso il metodo scientifico presume sempre il riferimento a un oggetto esterno al pensiero, riferimento che è accertato per mezzo dell'esperimento. Ma il "pragmatismo", o "pragmaticismo", di Peirce è soprattutto una teoria del significato. La teoria pragmatica della verità appare nel pensiero di James, secondo il quale "il vero è l'utile sul piano del pensiero" mentre, d'altra parte "il giusto è l'utile sul piano del comportamento". Anche per Dewey la verità è una forma di "appagamento", ma mentre in James questo appagamento può essere anche la capacità di dar soddisfazione a esigenze private e soggettive (per esempio quelle di natura religiosa), secondo Dewey la verità è la caratteristica di quelle idee che ci guidano in maniera efficace nella soluzione dei conflitti che si presentano nel nostro rapporto con l'ambiente.(17)
Note:
- Da Internet web.oneonline.it/dromano/appunti/paris 17.htm torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Mario Trombino, "La ricerca contemporanea" , volume terzo, Casa editrice Poseidonia, Bologna, maggio 2000, Pagine 591/592 torna al testo
- Ugo Avalle, Enzo Cassola, "Pedagogisti e pedagogie nella storia", volume unico, Casa Editrice Paravia, Torino, 1994, Pagina 498 torna al testo
- ibidem, pagina 504 torna al testo
- ibidem, pagina 505 torna al testo
- ibidem, Pagina 505 torna al testo
- ibidem torna al testo
- Uibidem, pagina 506 torna al testo
- Da Internet web.oneonline.it/dromano/appunti/paris 17.htm torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
- Da Internet Ibidem torna al testo
Bibliografia
Mario Trombino, "La ricerca contemporanea" volume terzo,Casa Editrice Poseidonia (Bologna),
Anno pubblicazione maggio 2000,Pagine 589/590/591/592
Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero "Filosofi e filosofie nella storia", volume terzo, Casa Editrice Paravia, seconda edizione 1992
Sini "Il pragmatismo americano", Casa editrice "La Terza", Bari 1972
Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero "Filosofi e Filolsofie nella storia" volume terzo, Casa Editrice Paravia, Anno Pubblicazione 1992, Pagine 406/407/408
Ugo Avalle ed Enzo Cassola "Pedagogisti e pedagogie nella storia", Casa editrice Paravia, Anno Pubblicazione 1994, Pagine da 497 a 518
 John Dewey nacque nel Vermont (USA) nel 1859. Dopo la laurea con una tesi sulla psicologia di Kant, nel 1894 passò ad insegnare alla University of Chicago dove, pur insegnando filosofia, dedicò grande impegno scientifico alla pedagogia. Prima della fine del secolo uscirono due opere fondamentali:
John Dewey nacque nel Vermont (USA) nel 1859. Dopo la laurea con una tesi sulla psicologia di Kant, nel 1894 passò ad insegnare alla University of Chicago dove, pur insegnando filosofia, dedicò grande impegno scientifico alla pedagogia. Prima della fine del secolo uscirono due opere fondamentali: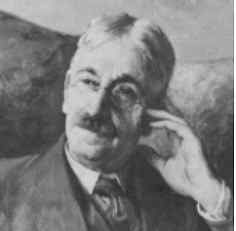 Dewey criticò, nella scuola tradizionale, la dimensione intellettuale e quella pratica e sostenne un apprendimento basato sul fare: Learning by doing (apprendere attraverso il fare). La scuola deve riprodurre al suo interno la società; essa è una forma di vita dove il bambino ha un'attività sociale e i suoi interessi diventano il centro del progresso educativo.
Dewey criticò, nella scuola tradizionale, la dimensione intellettuale e quella pratica e sostenne un apprendimento basato sul fare: Learning by doing (apprendere attraverso il fare). La scuola deve riprodurre al suo interno la società; essa è una forma di vita dove il bambino ha un'attività sociale e i suoi interessi diventano il centro del progresso educativo.